Capitalstatismo, capitalismo e mercato
Al tempo del marxismo trionfante, quando il vento della Storia sembrava soffiare verso le magnifiche sorti e progressive della rivoluzione proletaria, la bestia nera era il Capitalismo, in tutte le sue forme. Da una parte i padroni, piccoli o grandi, nazionali o soprannazionali, dall’altra i lavoratori sfruttati, quelli che, nella lotta contro i loro affamatori, null’altro avrebbero avuto da perdere all’infuori delle loro catene. Laddove il Comunismo aveva celebrato la sua vittoria, le cose non sembravano però tanto più rosee che nelle aborrite democrazie borghesi. Si dice che in Unione Sovietica circolasse questa barzelletta:”Sai che cos’è il Capitalismo? E’ lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. E il Comunismo? E’ esattamente il contrario!”.
Tant’acqua è passata sotto i ponti della Storia, da quei tempi. Il vento a un certo punto è mutato, il Walhalla degli Dei comunisti è miseramente andato in fiamme, fra il giubilo di qualche somarello che credeva esser giunta dopo tante iatture la Fine della Storia: non con il trionfo dello Stato prussiano, come sognava Hegel, e neppure con l’Aufhebung dello Stato borghese nella società senza classi e senza padroni, come sognava Marx, ma con l’affermazione su scala planetaria delle democrazie liberali a economia capitalistica. In realtà la Storia non finirà mai. Quella puramente umana finirà forse quando qualche meteorite di grosso calibro manderà fuori orbita o spappolerà questo granel di sabbia che di Terra ha nome; quella dell’Universo continuerà imperterrita per la sua strada, senza accorgersi di nulla: quante distruzioni avvengono ogni momento nel Cosmo? Infinite. Non ci sarà nessun Erodoto a raccontare quel ch’è successo. Dopo qualche millennio, magari gli abitanti di un altro pianeta, esaminando i resti del granel di sabbia vaganti negli spazi siderali, potranno fare una ricostruzione archeologica delle vicende che hanno avuto a protagonista l’homo insipiens.
Altro che società pacificata, senza più nemici a destra e a sinistra. Il nemico, più che il Capitalismo in sé, è diventato il liberismo, ben presto battezzato come “selvaggio”. E poiché il Capitalismo può non essere liberista (il sistema sovietico era di questo tipo; quello cinese d’oggi, pur con tutte le sue aperture, anche), mentre un sistema di mercato deve esserlo per forza, se non vuol cadere in contraddizione, ecco il sillogismo: tutto ciò che è liberista è selvaggio; il mercato è liberista; il mercato è selvaggio. La bestia nera oggi è il mercato, al punto che Giulio Tremonti, colbertista di ferro e ammiratore di Rathenau, proprio al tempo in cui faceva parte come ministro dell’Economia dei governi Berlusconi, coniò il termine “mercatismo”, in senso dispregiativo. Un bel paradosso, visto che i governi di Berlusconi erano stati bollati, fin dall’inizio, dalle sinistre, come espressione del liberismo selvaggio (fosse stato vero! Invece l’unico vero liberista della schiera, Antonio Martino, fu subito messo sotto naftalina).
In realtà il mercato è sempre innocente, se è mercato vero. E’ il Capitalismo spesso, quasi sempre, a non esserlo. Troppo ammanicato con il potere dello Stato, per ottenerne protezione e favori. Troppo incline a trattenere i profitti per sé e a scaricare le perdite sulla collettività. Troppo bramoso di posizioni monopolistiche favorite dalla legislazione positiva. Troppo avvinghiato alle rendite della proprietà intellettuale, dominante in tutti i campi attraverso il sistema dei brevetti e del copyright. In questo hanno ragione i “left libertarians” quando distinguono puntigliosamente Capitalismo e Mercato, respingendo il primo e accogliendo il secondo. Forse è solo una questione di significati da attribuire alle parole. Anche i filocapitalisti alla Rothbart quando parlano di Capitalismo non intendono il brutto sistema oggi dominante -aggravato, tra l’altro, dal monopolio statale della moneta, amministrata dalle banche centrali – ma intendono riferirsi al mercato puro.
Discorsi troppo sottili non solo per l’incolto Tremonti, ma anche per gli intrepidi sostenitori del secessionismo; i quali, come amano gli staterelli piccini piccini, chiusi entro le loro barriere, disprezzando le aggregazioni politiche più ampie e magari sputando sulla libera circolazione delle persone nell’area di Schengen , così amano le botteghe artigiane (di cui anch’io, sia ben chiaro, nutro nostalgia) e le fabbrichette dei padroncini (a molti dei quali anch’io tolgo tanto di cappello), aborrendo come il demonio le spaventose Multinazionali. Maledetto mercatismo e liberismo! Va bene il Capitalismo nostrano, magari protetto da dogane, ma gli stranieri se ne stiano fuori. E guai a delocalizzare, dando lavoro a chi non è della nostra razza e affamando i nostri fratelli.
Autentici no-global. Fossero meno rozzi, saprebbero che l’economista indiano Jagdish Bhagvati ha dimostrato come la globalizzazione, pur con tutte le sue ombre che nessuno vuol negare, ha portato ricchezza laddove prima c’era la fame e nel complesso ha fatto bene a tutto il mondo. Ha anche dimostrato che le Multinazionali – le cui malefatte, quando documentate, nessuno vuol disconoscere – di solito pagano i dipendenti meglio delle industrie indigene e rispettano più di queste le normative riguardanti la tutela del lavoro. Senza andare nei Paesi sottosviluppati, anche da noi è più facile trovare lavoro nero e operai sottopagati in una fabbrichetta che in una Multinazionale (sia detto a chiare lettere: se l’alternativa al lavoro nero è la chiusura della fabbrica e la disoccupazione, ben venga il lavoro nero).
Sono dati inoppugnabili. Ma l’ideologia è più forte della realtà. Scioperano a Piacenza i dipendenti di Amazon? Ecco levarsi le voci degli indipendentisti contro il mercatismo, il liberismo selvaggio, le multinazionali; ecco le imprecazioni contro la modifica dell’art.18 dello Statuto dei Lavoratori e il famigerato “Jobs act” di Renzi. Mi si permetta, una volta tanto, di spezzare una lancia a favore del bulletto di Rignano che, come sapete, ho sempre visto come il fumo negli occhi. In tutta questa faccenda articolo 18 e Jobs act c’entrano come i cavoli a merenda. Devono essere criticati per altre ragioni: il primo perché andava non riformato, ma abrogato (come avrebbe voluto Pannella nel suo breve momento di lucidità liberista); il secondo perché battezzato nella lingua dei barbari.
C’entrano come i cavoli a merenda anche il mercatismo, il liberismo e tutto il resto. Vediamo bene come stanno le cose. I dipendenti di Amazon scioperano perché hanno chiesto un aumento di stipendio che finora i dirigenti non hanno voluto concedere. Pretendono di averne diritto perché la Società è in piena crescita, gli affari vanno a gonfie vele, i profitti sono pingui, anche grazie all’impegno che i lavoratori hanno sempre dimostrato nel puntiglioso svolgimento delle loro mansioni. La Società risponde che le paghe sono già più alte di quelle correnti, che la sicurezza dell’ambiente lavorativo è ben tutelata, che i dipendenti godono di contratti assicurativi sulla malattia e di altri benefici. Normale dialettica delle relazioni industriali, quindi. Dov’è lo scandalo? Non credo che si possa parlare di sfruttamento. Detto questo, sarei felicissimo che i dipendenti di Amazon ottenessero l’agognato aumento di stipendio. Se grazie al loro impegno hanno migliorato la produttività del lavoro che svolgono, se lo meritano senza dubbio alcuno, né la Società può opporre problemi di costo del lavoro.
Consiglierei piuttosto di andare a guardare che cosa succede in imprese, neppur tanto piccole, e piuttosto floride, del tanto decantato Nord, veneto e lombardo in particolare. Dipendenti privi di tutela sindacale, perché le rappresentanze aziendali, non si a bene come, sono state estromesse. Ore di straordinario non pagate. Obbligo di lavoro anche di sabato e di domenica, senza timbrare il cartellino. Roba da padrone delle ferriere. Altro che liberismo mercatismo e capitalismo selvaggio. Altro che art. 18 e Jobs act e altre puttanate del genere. Delinquenza pura. Evidentemente, con protezioni in alto loco.

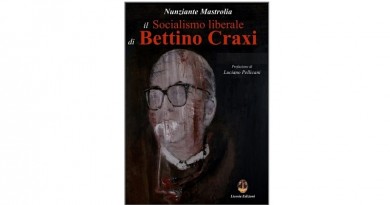
L’incolto Tremonti sostiene di non aver mai pronunciato la frase che lo “incriminò” eticamente. Dice che le parole esatte erano: “Non è che uno la cultura se la mangia”. Anche qui, forse, siamo in presenza di diversità di significato da attribuire alle parole o al senso delle frasi. Un po’ come “capitalismo”, andrebbe stabilito se possa intendersi un accumulo di capitale o una sua diffusione. Mi domando, però, come il sia pur a volte irritante ma comunque colto Sgarbi possa celebrare un matrimonio rinascimentale con il colbertiano. A che scopo, poi? Tremonti i voti non ce l’ha perché è una sorta di “tecnico prestato alla politica”, altra insopportabile definizione visto che anche Jago era un tecnico prestato alla politica. Grandi capitali per finanziare il movimento non credo li abbia personalmente. Possibile che il nome di Tremonti richiami capitali posseduti da altri? O non è forse un nome controproducente? Non lo sarebbe se fosse speso per liste protezionistiche come la Lega o nazionalistiche come Fratelli d’Italia. Non lo sarebbe in liste confessionali del tipo Casini – Rotondi. Andrebbe bene anche nell’accozzaglia cattosocialista rappresentata da Forza Italia. Ma in un movimento con poche possibilità di ottenere risultati sufficienti a superare le varie soglie di sbarramento, non vedo quale apporto possano dare figure di certo non popolari. Né vedo quale contributo culturale possano fornire in una formazione dal nome ambizioso. Misteri italici? O solo miei… sgarbati pensieri?
Breve momento di lucidità liberista, quello di Pannella? Non direi. Se ne è andò via da Malagodi perché quest’ultimo era troppo morbido nei confronti dei monopoli di stato. Furono i confusori del linguaggio a chiamare gli scissionisti “sinistra liberale”, quando invece più lontano dallo stato si sta e più si è individualisti e liberisti. E il posto dei liberisti non può stare a sinistra. Negli anni settanta i radicali ebbero il torto di glissare sui problemi economici privilegiando le questioni sui diritti civili. Che però non sono mai oggettivamente separati dalla libertà di operare, intraprendere, produrre e commerciare. Un po’ come l’unità dei cattolici in politica mise insieme rosminiani e dossettiani, incompatibili tra di loro, nelle liste radicali si trovavano candidati che la pensavano in materia diametralmente opposta sui temi economici ma che avevano una visione comune sui temi della laicità, del potere giudiziario, dell’antiproibizionismo. Ma liberale, liberista e libertario credo che Pannella lo sia sempre stato. Più brevi furono le sue partecipazioni a Giovani Sinistre Liberali (anche lui, in questo, contribuì alla confusione semantica), a proposte di listoni laici comprendenti anche i comunisti in funzione anticonfessionale (unica uscita nel 1959 alla quale Togliatti rispose negativamente sostenendo che l’illuminismo fosse peccaminoso, un Tremonti ante litteram), a giri di valzer con Craxi e parentesi liberalsocialiste alla Carlo Rosselli. Contraddizioni ci furono, è vero. Ma preferirei dover fronteggiare quelle contraddizioni piuttosto che le evidenti incoerenze delle rivoluzione arcoriane che di liberale hanno solamente il nome. O al massimo la copertura di Antonio Martino.
Per come la vedo io, la delinquenza con protezioni in alto loco sta altrove, ad es. nel tanto beneamato meridione che nel terzo millennio ha ancora un perfetto ed efficiente caporalato spietato gestito dalle mafie locali, che schiavizza i neri di Rosarno o Villa Literno, dove la trimurti sindacati-ispettorato-sbirri misteriosamente sembra non esistere o trovarsi in stato di animazione sospesa e panta rei come se nulla fosse in perfetto stile magna grecia e magna-magna, con una alzata di spallucce sull’ineluttabilità di un destino per il sud da sempre cinico e baro, ma molto comodo per alcuni.
Nel lombardo veneto i dipendenti scontenti se vogliono possono sempre rivolgersi ai sindacati; se non lo fanno è perchè hanno capito tutto. Spesso sono amici del titolare e vanno a lavorare anche con qualche linea di febbre perchè sanno che lui è uno di loro, che si fa il mazzo quadro, che subisce l’oppressione di equitalia, che è costretto a scoperchiare i capannoni quando c’è la crisi, fino alla extrema ratio del suicidio contro la foga predatoria istituzionalizzata.
Delinquenza pura sì, ma dello stato.
Tutto vero quel che si dice sulla situazione dei rapporti di lavoro in vaste aree del Meridione, soprattutto per quanto riguarda le attività stagionali di raccolta nel settore agricolo: una vergogna che è stata più volte denunciata, senza che nulla finora sia cambiato. Qui si voleva però rimarcare quello che pochi o nessuno dicono: anche nella civilissima Lombardia non è tutto oro quello che luccica. Non ho difficoltà a far nomi e cognomi: nella ditta Pinco&Pallino (che si occupa di tecnologia di impresa, con sede a Cabiate, in provincia di Como) i tecnici di laboratorio sono inquadrati nel contratto del commercio, con stipendi più bassi di quelli previsti dal contratto dei chimici; il che può anche essere regolare, visto che la ditta vende servizi per il cui supporto il laboratorio chimico svolge una parte minoritaria dell’attività complessiva. I dipendenti percepiscono 14 mensilità, ma per contratto sono tenuti, quando richiesto, a lavorare gratuitamente in ore supplementari il sabato e la domenica. Regolare anche questo, forse, visto che il contratto è stato liberamente sottoscritto, anche se le ore non pagate in termini marxiani si chiamano pluslavoro, che genera plusvalore. Non è affatto regolare invece che di sabato e di domenica i lavoratori siano obbligati dalla direzione a non timbrare il cartellino. Se succedesse un incidente con danni alle persone? Durante la pausa pranzo i tecnici di laboratorio sono costretti a consumare i pasti in ambienti malsani, respirando i residui dei veleni chimici di cui l’aria è impregnata. Tutto però è formalmente ineccepibile, visto che la ditta, i cui servizi consistono nelle certificazioni di igiene ambientale e occupazionale, autocertifica anche per se stessa la salubrità del proprio ambiente di lavoro. Questo si chiama conflitto di interessi. Nessuno dei dipendenti ha avuto il coraggio finora di denunciare lo sconcio, per timore di ritorsioni. I sindacati sono stati estromessi dall’azienda, non si capisce bene come e grazie a quali protezioni, visto che l’attività antisindacale è sanzionata dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori e, sul piano penale, in caso di inosservanza del decreto del giudice o della sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione, dall’art. 650 c.p. Evidentemente le mafie esistono anche al Nord.
L’azienda in questione, più che di tecnologia di impresa, si occupa di “ingegneria dei rapporti con con la Regione Lombardia” e di “ricerca nel settore della complicazione burocratica” a spese delle imprese (quelle vere, che vivono immerse nella “pressa” del mercato), con la scusa della sicurezza: ne traggono beneficio tanto il socio unico quanto i dipendenti. Non sottovaluterei la differenza tra i ritmi e la selettività di un lavoro basato sulla prestazione e sul mercato (internazionale) e un incarico da certificatore, sostanzialmente parastatale (i clienti sono aziende private, ma obbligate dallo Stato a ricevere certificazioni inutili: come avveniva per il bollino blu automobilistico o ancora avviene per la “revisione”).
Chiaro che in questo contesto il gioco è al ribasso (cosi come lo stipendio e il rapporto tra retribuzione e ore lavorate… o investite in meeting aziendali). La soluzione non è tanto invocare la presenza dei parassiti sindacali, quanto quello di abbandonare le acque tranquille di un porto protetto o del pollaio (il “padrone” è sfruttatore e usa metodi “mafiosi”, ma è anche capace di portare l’azienda con tutti i dipendenti sotto l’ala protettrice di una mafia più grande) e affrontare lo spazio aperto del mercato, senza contratti nazionali, senza sindacati, senza padroni mafiosi: contando solo sulle proprie competenze, sulla propria forza e sul proprio equilibrio morale.
Caro Leporello, è evidente che in un contesto anarchico, dove il libero mercato è davvero sovrano, le cose starebbero come dici tu: nessuna impresa parassitaria che estragga le sue rendite da una clientela obbligata dalle leggi dello Stato a richiederne i servizi; nessun contratto di lavoro nazionale; nessuna pattuizione contrattuale con valore erga omnes; nessuna garanzia costituzionale del diritto di sciopero; ridimensionamento del potere dei sindacati, che diventerebbero libere associazioni a tutela degli interessi di categoria, prive di ogni veste para-istituzionale Dico soltanto che, nel contesto attuale, se un’impresa privata vive parassitariamente sotto l’egida dello Stato, deve fare il piacere di applicare coerentemente le leggi dello Stato, in primis lo Statuto dei Lavoratori e le normative che regolano le relazioni industriali: troppo comodo essere con lo Stato per i vantaggi e i privilegi che se ne traggono e contro lo Stato per gli obblighi di legge. Quanto ai lavoratori che si guadagnano da vivere come dipendenti di quelle imprese, è ingeneroso fargliene una colpa, dato che in un mercato rattrappito qual è quello ora dominante le possibilità di scelta del posto di lavoro risultano a loro volta rattrappite. Lo Stato, il para-Stato, il parassita di Stato offrono sbocchi che hanno spesso come unica alternativa la disoccupazione. Mi viene in mente compare Carmine, l’oste della novella “Malaria” di Giovanni Verga, il quale prima impreca contro la ferrovia che gli ha sottratto gli avventori, ma alla fine, se non vuole morire di fame, deve accettare un impiego come casellante…
Il collegamento tra le condizioni dei lavoratori e il “capitalstatismo” di certi imprenditori a me sembra evidente, nel male, ma anche nel bene. Sono d’accordo: quando si vive dentro un sistema, è corretto (o almeno coerente) accettarne le regole: se accetto il vantaggio di lavorare protetto dall’ombrello di un sistema mafioso (senza il quale l’azienda e i relativi posti di lavoro, non esisterebbero), ben sfruttato dal “prenditore” in questione, non posso aspettarmi un metodo onesto, anche nel rapporto con i dipendenti. Eppure i vantaggi ci sono: minore enfasi data alla competitività basata sulla prestazione (ma, d’accordo, competizione al ribasso, sulla quantità), ottenimento del “posto” di lavoro (questa, sono d’accordo, è merce rara… anche se di “lavoro” in giro ce ne è moltissimo…).